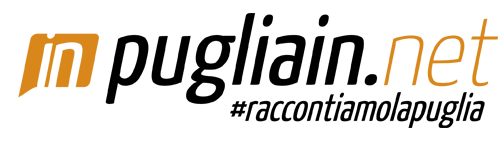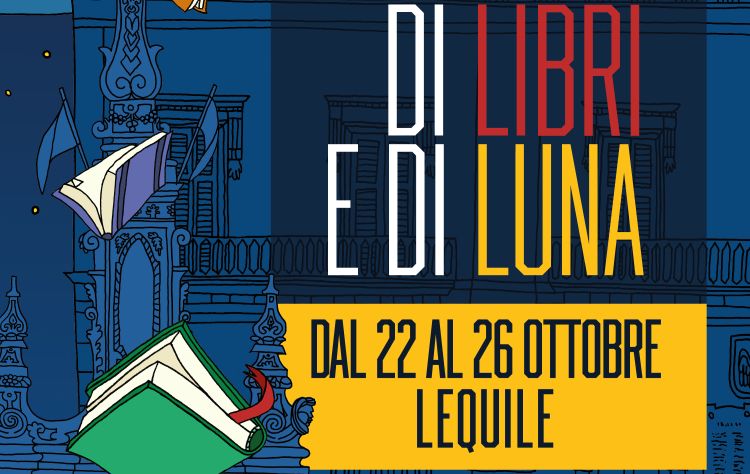Può sembrare quasi una provocazione di questi tempi portare nei teatri la canzone napoletana, inducendo a riflettere sulle polemiche scaturite dopo il Festival di Sanremo. Vista infatti la scarsa qualità delle canzoni presentate nell’ultima edizione adottando stili non consoni alla nostra tradizione, perché non riappropriarci della nostra cultura musicale riportandone alla memoria le radici, lontane da rap, rock, hip-hop e simili? E cosa c’è di meglio della canzone napoletana quale biglietto da visita e carta di identità? In special modo quando ci si ispira a quel percorso rigorosamente musicologico già indicato dal maestro Roberto De Simone alla fine degli anni ‘60. Sulla stessa strada si sono incamminati i sei musicisti che compongono l’Archetipo Ensemble, un gruppo di ispirazione acustica nato ad Aprilia nel 1995 col nome di Almalatina. Oggi esso fa parte dell’associazione culturale “Vaso di Pandora” e svolge un accurato lavoro di ricerca storico e filologico ad ampio raggio: con orgoglio oggi può mostrare il premio “Foyer des Artistes” assegnatogli dall’Università “La sapienza” di Roma per la divulgazione del patrimonio musicale italiano. A luglio scorso è stato invitato a esibirsi nel Cortile della Pigna all’interno dei Musei Vaticani.
Nel concerto di giovedì scorso al Teatro Forma abbiamo assistito ad un excursus della canzone napoletana a cominciare da villanelle e “calascionate” (suonate con il colascione strumento a tre corde) del 1500 fino a quelle del dopo guerra. Il tutto spiegato (e cantato) con dovizia da Maria Ausilia D’Antona, vocalist dell’ensemble. Dalle canzoni tradizionali e di autore anonimo (“Fenesta vascia”, “Oi mamma ca mò vene”) si passa a Salvatore Di Giacomo (“E spingule francese”, “Era de maggio”, “E cerase”) a Libero Bovio (“Guapparia”) e Raffaele Viviani (“A rumba de scugnizze”). E viene descritto anche il trasferimento della musica dai salotti delle case dei nobili alla strada, dove il pianoforte deve necessariamente cedere il posto a chitarre e mandolini. Ecco la figura dei “posteggiatori”, musicisti vagabondi di solito vicino alle stazioni di posta, e la diffusione delle “copielle”, fogli con testi e spartiti delle canzoni distribuiti ai passanti.
L’ensemble è stato capace di trasmettere tutta la passione sanguigna che contraddistingue lo spirito partenopeo, la gioia di vivere, il calore, la vitalità che esorcizza la miseria, e la solarità di una terra baciata dal sole. Una carrellata di classici divenuti popolari che hanno inevitabilmente contagiato il pubblico per la loro cantabilità: “Je te vurrìa vasà”, “Dicitencello vuje”, “Scalinatella”, “Palummella, zompa e vola ”, “Te voglio bene assaje” sono canzoni immortali che fanno parte del nostro patrimonio culturale. La scrupolosa professionalità dei musicisti, il loro rispetto delle sonorità originarie nel custodire le memorie storiche, e l’abilità nel rinnovare le emozioni hanno fatto il resto. Maria D’Antona dalla voce della popolana fiera e verace, Marilena Serafini al liuto e mandola per rievocare sensazioni e suoni antichi, le chitarre di Gabriele Falcone (direttore di scena) e Sergio Trojse, il basso di Alfredo Trojse e le percussioni di Maria Assunta Recalina, hanno ricreato le atmosfere adatte per rievocare tempi e ambienti che hanno dato vita alla canzone italiana.
Potevano mancare le tarantelle? Assolutamente no! Ed ecco le tammurriate con tanto di nacchere e tamburello: “Vesuvio” di E’ Zezi e soprattutto la intramontabile “Tammurriata nera” scritta nel 1944 da Edoardo Nicolardi e Giovanni Gaeta. Il bis è per “Malafemmena” di Totò, e il pubblico canta in coro.
In un momento in cui si sente la mancanza dalle scene della Nuova Compagnia di Canto Popolare accogliamo con vero piacere il progetto dell’Archetipo Ensemble.
Lo spettacolo era (fuori abbonamento) nel cartellone di “Nel gioco del jazz”.